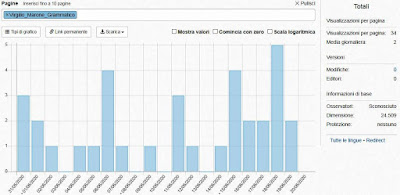È un triste anniversario il secondo
dalla morte di Lorenzo il Magnifico. Un gruppo raccolto presta profonda
attenzione ai cantori diretti dal musicista Heinrich Isaac mentre intonano
il Lamento per la morte di Lorenzo Il Magnifico. Il pittore Sandro Botticelli ascolta
rapito a occhi chiusi e, al termine dell’esecuzione, mentre il coro si
allontana, li spalanca fissando Poliziano.
Botticelli
Angelo, in sogno. Era Orfeo, il tuo
Orfeo. Ma fatto a pezzi e divorato dalle cavalle di Diomede.
Poliziano
I nostri miti vanno a pezzi e si
confondono. Chi farà un nuovo componimento di quello che resta di Orfeo? Forse
tu, Enrico, tu che sei un compositore?
Isaac
Ho già composto il Lamento. Le pause di
silenzio hanno ancora la meglio su qualsiasi nota.
Marsilio Ficino
Divino Lamento!
Poliziano
È la testa, la testa, che continua
imperterrita a cantare!
Isaac
La testa del poeta. Ma in un pentagramma
vuoto.
Poliziano
Sì, mio caro, dovrà essere la testa di
un altro poeta a ricomporre i nostri frammenti in forme nuove. E Orfeo tornerà
a vivere e cantare come Dioniso dopo che fu smembrato dai Titani, ispirato dal
dio del teatri.
Ficino
L’anima finalmente libera dal corpo
nelle onde armoniche della conoscenza divina.
Botticelli
La tua testa, Angelo, la mente che
ispirò la mia Primavera, irrigata da quelle acque. Le nozze di Mercurio e
Filologia, la nostra scienza che diventa divina. E lo sgomento della
trasfigurazione placato dal calore di quel sole che dava luce ai nostri sogni:
Lorenzo.
Poliziano
E ora c’è il figlio Piero, nostro
crepuscolo. No, il poeta non scriverà più. Lo studioso, l’erudito, quello sì
vorrebbe ancora scrivere, magari con un cappello da cardinale in testa. Il
maestro di scuola che ha cercato di educare Piero. Bocciato in politica e in
religione. I Medici non riescono più a curare nemmeno se stessi.
Banchiere
La partita era doppia e ora sono solo
uscite. Avete messo in conto un’Età dell’Oro che non si è concretizzata.
Dimenticate che i registri degli uomini sono a immagine e somiglianza del Libro
della Vita? In fatto di entrate, per il Giorno del Giudizio, dovete ammettere
che il Savonarola è un ottimo contabile. Ma, scherzi a parte, è consolidato che
quando languono i registri contabili anche le pagine dei libri di poesia
restano vuote.
Poliziano
Ma non parlavamo di un sogno? Già,
parole, parole derubricate. La realtà è che un povero Angelo ha perso le ali di
porpora e se ne resta a Firenze con le penne bruciacchiate da tutti questi falò
delle vanità. Vi piace questa nuova trama? Però non chiedetemi di scriverla:
non mi sento bene.
Botticelli
Forse è giusto che le forme che abbiamo
creato perdano la loro consistenza. La nostra era una prospettiva umana, solo
umana. I libri di geometria restano senza lettori, la tela viene strappata
dalla sua intelaiatura e si chiude in se stessa.
Ficino
Eppure so che stai lavorando a un tema
già tracciato dal grande Apelle, la Calunnia, non è vero? I nostri
classici dovrebbero venirci in aiuto. Ma forse è una menzogna che ci siamo
raccontati per troppo tempo.
Poliziano
La verità è che tu hai contribuito a
renderli evanescenti traducendo il tuo Plotino, che gli ha tolto materia e vita
nel nome di una luce che non illumina ma annienta. Una verità che non ha
bisogno dell’essere umano e, a volere essere logici fino in fondo, neanche del
tuoi filosofi neoplatonici.
Ficino
Io ho tentato di convincere Savonarola a
salvare la saggezza degli antichi. E tu sai bene quanto i Padri della Chiesa
abbiamo posto le fondamenta in quei fedeli discepoli di Platone.
Poliziano
Sarebbe ora di fare chiarezza, caro
Marsilio, su quanto sia davvero di Platone e quanto di questi che dici “fedeli
discepoli”. E io non trovo mezzo migliore che usare il pensiero tutto terreno
di Aristotele, quello che ora possiamo finalmente leggere dal greco. Ma tu,
Sandro, dimmi, intendevi dipingere davvero questa specie di nostra “grande
menzogna” nella tua Calunnia?
Botticelli
La mia, poeta, vorrebbe essere una
composizione – ho visto che il termine piace a te come al nostro musico – di
tutti quei sensi di colpa che proviamo di fronte una realtà che è così cambiata
all’improvviso, per essere assolti da Dio e dagli uomini…
Poliziano
… e dal tuo Savonarola.
Botticelli
Che è stato anche tuo. E nostro. E mio
lo sarà ancora.
Poliziano
Metterà il saio alle tue bellezze
femminili.
Botticelli
Ma la Verità resterà nuda.
Poliziano
La verità è che i cavalli del re di
Francia, ben più famelici di quelli di Diomede, ridurranno a brandelli i nostri
sogni. Come Orfeo, ancora una volta fatto a pezzi, ma da queste nuove baccanti,
queste beghine miserabili e fanatiche.
Botticelli
Carlo VIII ha in mente una crociata.
Ficino
E forse riconquisterà anche la Grecia,
com’era nei sogni di chi ispirò la creazione della nostra Accademia fiorentina,
il grande Gemisto Pletone.
Poliziano
Che era pagano - e lo sapete bene. E i
suoi nuovi discepoli – i tuoi? - diventeranno tizzoni per nuovi roghi. No, voi
vaneggiate. E tu, Sandro, sei così stanco dei tuoi colori? Grigio e nero: si
disegnano così i nostri tempi.
Botticelli
Lascerò un po’ di rosso per i sogni da
cardinale.
Poliziano
Ti ringrazio per l’auspicio. Che musica
è di moda a Roma, compositore?
Isaac
Polifonia, come da noi, e sempre per un
padrone solo. Là domina un altro dei nostri fiamminghi, Josquin Desprez, per
questo me ne andrò in Germania, dal nostro sacro romano imperatore
Massimiliano. E sarà musica sacra, anche lì.
Poliziano
Io ho sacralizzato il profano. Ho
riportato ninfe e pastori sulla scena dove prima c’erano solo santi. Nessuno ha
ancora fatto qualcosa di simile alla mia Fabula di Orfeo.
Banchiere
Quelli che voi chiamate ninfe e pastori
crescono di numero ogni anno di più e le toppe che aumentano sui loro miseri
vestiti stanno a significare un ribaltamento della domanda e dell’offerta.
Cominciano a diventare troppi, scappano in città e sognano anche loro: il regno
di Dio sulla terra. L’aumento, da un punto di vista semplicemente economico, è
un bene: i padroni della terra, i clienti delle nostre banche, potranno pagarli
di meno perché saranno di più a chiedere lavoro. E le ricchezze che sembra
verranno dalla via delle Indie aperta da Colombo non miglioreranno certo la
situazione, perché sappiamo in quali tasche finiranno. Politicamente però
questo sarà un grosso problema, anzi, lo è già. E voi, come me d’altronde, non
avete risposte.
Poliziano
Il Libro della Vita…
Ficino
Dovrei interrogare le stelle. Questo
argomento è nuovo per me.
Botticelli
“Et pastores erant in regione
eadem vigilantes, et custodientes vigilias noctis super gregem suum. Et
ecce angelus Domini stetit juxta illos”… Luca 2, 8-9…
Poliziano
Io ricordo che un tempo tu, Enrico,
mettesti in musica una canzone triste del nostro Lorenzo: Un dì lieto giammai…
Isaac
Ricordo. È solo un ricordo.
Poliziano
E io avevo scritto un breve poema, una
Selva, Sylva in scabiem, su un morbo terribile e
inestinguibile – “funesto, grande ingegno del dolore”! – fisico e morale – “da
tutto il corpo un marciume biancastro,/ dovunque stilla un sangue così denso:/
mai una tregua a tutti questi tormenti”. C’è una musica per tutto questo? C’è
ancora una volta la possibilità di chiamarla finzione? Una poesia non è
indispensabile che sia vera subito. E questa malattia…
Buio improvviso. Silenzio. Commento
musicale: Heinrich Isaac, Fortuna desperata: Nasci, pati, mori.
Luca Traini
tratto da Teatri di guerra (Ideazione 1999, Frammenti scelti)
EPISODIO I Agatarco di
Samo ad Atene: questione di prospettive
https://lucatraini.blogspot.com/2019/12/teatri-di-guerra-1-agatarco-di-samo-ad.html
EPISODIO II Ambivio
Turpione: commedie?
https://lucatraini.blogspot.com/2020/02/teatri-di-guerra-2-ambivio-turpione.html
EPISODIO III Rosvita di
Gandersheim: avanguardia in clausura
https://lucatraini.blogspot.com/2020/04/teatri-di-guerra-3-rosvita-di.html
EPISODIO IV Albertino
Mussato e Dante Alighieri: teatro horror per virtù civiche
https://lucatraini.blogspot.com/2020/06/teatri-di-guerra-4-albertino-mussato-e.html
EPISODIO VI Pietro
Metastasio: Arcadia al potere
https://lucatraini.blogspot.com/2020/10/teatri-di-guerra-6-pietro-metastasio.html
EPISODIO VII Georg
Bücher: teatro di scienza della rivoluzione
https://lucatraini.blogspot.com/2020/12/teatri-di-guerra-7-georg-buchner-teatro.html