Mestum extrico pulmone tonstrum,
Sed gaudifluam pectoreis arto procellam arthereis
Cavo fuori dai polmoni un mesto
turbamento,
Trattengo nella trachea l’allegria che scorre tempestosa
Hisperica Famina
Mare
quoque undosum biluosumque in turbinosa
cordis
profunditate hominis et in ipsa ratione
E
anche il mare ondoso e abitato nella tempestosa
profondità
del cuore umano e nella stessa ragione
Virgilio Marone Grammatico
Cosa ci fa un grammatico che compone opere per
quasi duecento pagine e sembra rivolgersi alle folle di Roma antica nella
Tolosa del VII secolo, nel momento di massima depressione demografica (e non
solo) dell’Europa Occidentale? E soprattutto chi è? Il nome sembra fittizio, il
regno merovingio dopo Dagoberto è sempre più in crisi e le sue opere hanno poco
a che fare con il classicismo latino del vicino regno visigoto. Nella loro oscurità
ricordano più lo stile degli Hisperica Famina di certi scrittori che venivano dall’Irlanda o dall’Inghilterra.
Per analizzare questo mistero, che mi appassiona
dall’esame universitario di latino medievale del remoto ’86, partirò da
un’abbreviazione che attribuisce a un non meglio identificato retore Emilio,
roba da far impallidire le sigle degli enti sovietici o del nostro parastato di
una volta: “Disse con eleganza SSSSSSSSSS.PP.NNNNNNN.GGGG.RR.MM.TTT.D.CC.AAAAAAA.IIIII.VVVVVVV.O.AE.EEEEEEE.
E questa è la soluzione: sapiens sapientiae sanguinem sugens sanguissuga
venarum recte vocandum est (“il sapiente che sugge il sangue della sapienza
deve giustamente essere chiamato sanguisuga delle vene”)”.
Un inizio a scoppio, tanto per invogliare a un
argomento complesso quanto mai intricato. E più che di abbreviazione si
dovrebbe parlare di “scomposizione delle parole”, “scinderatio fonorum”, che è
qualcosa di più problematico, di iniziatico: “Le parole si dividono per tre
motivi: il primo è per mettere alla prova i nostri alunni nel ricercare e
trovare le cose difficili; il secondo è per dare eleganza e struttura al discorso;
il terzo è perché tutte le cose iniziatiche devono essere rivelate soltanto
ai saggi… Scrittori enigmatici e di ingegno sottile”. C’è quindi anche una “scinderatio”
attribuita niente meno che a Cicerone. Che naturalmente non ha nulla di
ciceroniano…

I misteri laici della parola hanno inizio. I testi
sono due, 15 Epitomi e 8 Epistole, ma l’argomento è uno solo: la
grammatica. Un testo scolastico quindi, sulla scia delle grammatiche
tardoantiche di successo, quella di Donato (IV sec.) su tutte, ma anche di
opere enciclopediche finalizzate allo studio come le Nozze di Mercurio e Filologia di Marziano Capella (V sec.) o le più
recenti Etimologie di Isidoro di Siviglia (inizio VII sec.): tentativi colossali di salvaguardare il patrimonio
della letteratura latina in un’età storica di profondi cambiamenti. Perché il
medioevo, nonostante un’immagine vecchia a morire, è stato un’epoca di continue
trasformazioni e l’alto medioevo, specie prima dell’impero carolingio, ha poco
a che vedere con l’immagine tradizionale di massa legata al medio e tardo
medioevo italiano della Lega Lombarda, delle città marinare o di Dante.

Ma si diceva: un’opera di grammatica per le
(pochissime) scuole dell’epoca. Peccato che buona parte dei contenuti siano
assolutamente inventati e gli autori citati con numerosi esempi dei perfetti
sconosciuti. Si va da un vecchio Donato di Troia vissuto mille anni che avrebbe
fondato una scuola nella Roma di Romolo a tre Virgili (di cui il nostro sarebbe
l’ultimo) di cui il primo, Virgilio d’Asia (alunno del Donato millenario),
avrebbe scritto 70 volumi sulla metrica, a tutta un’altra serie di insegnanti
sparsi fra Europa, Africa e Asia fino all’India, fino al nonno (“Martule, uomo
dotto e di bell’aspetto”) e allo zio dell’autore (“Samminio, gioia di mamma sua”).
E al suo maestro per eccellenza dal nome troiano, Enea, assolutamente irreperibile
in qualsiasi fonte storica.
Tutto questo insistere sulla matrice troiana del
suo lavoro è, a mio modo di vedere, da un lato un congiungersi alle origini
leggendarie del popolo romano, come cantate dal più famoso – e reale
– Virgilio, e della sua lingua, il latino. Dall’altro potrebbe essere una
conferma dell’elaborazione dell’opera in Francia. È proprio in questo periodo
che prende forma scritta la leggenda dell’origine troiana del popolo franco,
attestata nella Cronaca di Fredegario
e poi nella Historia Daretis Frigi de origine Francorum.

Dopo questa breve parentesi geopolitica torniamo
all’irrealtà del corpo docente del Grammatico. Ecco allora sfilare Balpsido, Galbungo,
Gergeso, Blasto, Vulcano, Sagillo: solo per fare qualche nome e una specie di
scioglilingua. Frotte di maestri e discepoli per dibattiti e convegni le cui
cifre, rapportate a oggi, comporrebbero una folla da palazzetto dello sport. E
questo in una realtà scolastica disastrata come quella della Francia del VII
secolo! Sembra più nostalgia dei bei tempi andati quando, come scrive lo
storico Manlio Simonetti, “la Gallia del IV/V secolo fu famosa per le sue scuole, ma…
il fatto che Giuliano Pomerio (2a metà V sec.) da maestro di scuola sia
diventato prete è emblematico del nuovo stato di cose”. Ma neanche la nuova
cultura ecclesiastica se la passava bene: “In Gallia la condizione di favore di
cui la chiesa si trovò a godere provocò una completa simbiosi con la classe
politica: di qui politicizzazione, mondanizzazione, coinvolgimento nella
dominante barbarie, per cui, imbarbarita, neppure essa fu in grado di operare
culturalmente in modo efficace.” (M. Simonetti in Romani e barbari: le letterature latine alle origini dell’Europa
(secoli V-VIII), Carocci, 2018).
La fondamentale edizione italiana curata da Giovanni Polara, edita nel 1979
E poi ci sono quelle stranezze ancora più strane. Cito solo due
casi.
La teoria delle dodici specie di latino di cui una
sola in uso (Epitome I,4). L’esempio
che propone, ricco di tutta una serie di impliciti riferimenti, è quello del
fuoco, che dalla forma basilare “ignis”, in una specie di progressione celeste,
diventa “quoquihabin”, “ardon”, “calax”, “spiridon”, “rusin”, “fragon”, “fumaton”,
“ustrax”, “vitius” (ma nel senso che col suo “vigor” ridà vita “vivificat” le
membra quasi morte), “siluleus”, “aeneon” (“dal dio Enea che dimora in esso e
dal quale viene il soffio degli elementi”). Ancora Enea, il suo adorato maestro
(davvero adorato), e l’ascendenza troiana.
Lo scontro armato fra due grammatici con tanto di
schiere di 3,000 di guerrieri per parte in una questione di verbi incoativi (Epistola III,10). Fra le righe della
lettera emerge il sogno di una massa
critica di letterati: il sogno proibito del nostro Virgilio e del suo
minuscolo club esoterico.
Leggendo queste pagine, a volte ho sentito spirare
quell’aria di grande menzogna che avvolge la Storia Augusta, di cui ho scritto nel mio Il Dittico di Aosta. Ma qui non si tratta di una storia manipolata
in senso politico dove tutta una serie di falsità viene attribuita a personaggi
esistiti realmente, opera di gruppi di potere che hanno ancora qualche
probabilità di vittoria. No, qui tutti i protagonisti di questa epica
grammaticale sono – o sembrano – tutti inventati. Come il latino proteiforme
con cui parlano e scrivono Virgilio e i quattro gatti senza speranza a cui si
rivolge. Se Franchi, forse gli ultimi maestri della tradizione laica.

A una prima occhiata il tutto sembra l’opera di un
folle (e qualche illustre studioso l’ha preso come tale). La
seconda cosa che viene in mente è una grande parodia. Passaggi come “quanto più
si vuol difendere la propria autorità, tanto più si scopre che essa è una falsa
menzogna” (Epitome V,9) o quest’altro,
degno di Ionesco, “i dotti usarono le parole più rare non perché volessero
creare problemi agli ascoltatori, ma per aiutarli, in modo che, vedendo queste
parole scritte nelle loro opere noi le possiamo usare come comuni e note” (Epitome V,15), fanno riflettere. Non è un caso infatti che Giovanni Polara
- cui si deve il mostruoso lavoro di edizione dei testi originali e la prima (e
unica) traduzione in italiano, insieme a Luciano Caruso, delle due opere nella
mitica edizione Liguori del ’79 – nella sua Introduzione citi Alfred Jarry e scriva: “Questo autore bizzarro certe volte sembra vissuto almeno mille anni
troppo presto, questo strano personaggio su cui sono stati pronunciati i più
disparati giudizi”. Poi, però, ci sono i recenti studi di Caterina Babino - parliamo della prima metà di questo decennio - che mettono in discussione
buona parte delle precedenti interpretazioni e propongono un autore che si rivolge
a una ristretta cerchia – verrebbe voglia di dire una setta – di colleghi con
un linguaggio iniziatico volto a rivendicare un’aura di autonomia di pensiero
alle scienze umane rispetto al sempre più preponderante dominio della teologia.
Dietro la grammatica vediamo quindi emergere la filosofia che, specie dal Cratilo di Platone in poi, aveva fatto
dello studio del discorso, della connessione fra le parole e della
corrispondenza tra significante e significato (vedi anche le Etimologie di Isidoro) l’arma principe
nel suo incontro-scontro con la dimensione del mito, del sacro.

Sarà un caso che il nostro Grammatico inizi la sua
prima Epitome profondendosi proprio nella
definizione della parola “sapientia”? “Essa deriva dal sapore, perché, come
succede nel senso fisico del gusto, così anche nell’attività dell’anima c’è un
gusto che è capace di sentire la dolcezza delle arti e di distinguere la forza
delle parole e delle frasi, respingendo tutto ciò che è amaro e cercando il
dolce. E amare per noi sono le affermazioni che contraddicono la verità delle
dottrine filosofiche, dolci invece quelle che ci danno la conoscenza di
ciascuna arte e materia. Questo sapere è duplice, celeste e terreno, cioè umile
e sublime”. E’ uno dei passaggi più belli. E coraggiosi, perché la tradizione
della teologia, specie quella latina (dal “Credo quia absurdum” di Tertulliano
ai meno estremi ma sempre severi e tormentati Gerolamo e Agostino), pur
attingendo a piene mani dalla multiforme tradizione filosofica pagana, aveva
privilegiato la strada dell’amarezza, del rifiuto di quanto non indispensabile
alla scrittura e alla Scrittura, cioè, il contenuto: grammatica per imparare a
leggere e scrivere e basta. Non era ancora nato un Giovanni Scoto Eriugena,capace di offrire una sintesi, né un imperatore come Carlo il Calvo in grado didifenderla. Virgilio Marone Grammatico, se mai è il “Vergilius tolosanus” di
cui parla Abbone di Fleury, viveva nella più umile Tolosa del duca Boggio, i
cui non certi nonno e padre erano stati assassinati su istigazione di Dagoberto.

Tutto è “forse” qui. Tranne le certezze di AngeloMai, il cardinale filologo in corrispondenza con Leopardi, che col santo abate
di Fleury trovò subito un’intesa quanto alle origini del Nostro: il problema
dei problemi . E’ vero che, nell’Epitome
IX,2, Virgilio fa dire a un altro dei
suoi retori ignoti, Terrenzio (con due erre), “È necessario che i Galli siano
ingannatori” e sembra un nuovo Epimenide di Creta (che ho già trattato per altri versi nel mio Classicismo con rabbia), tuttavia la qualità dell’opera, come
abbiamo già sottolineato, ha poco a che fare con la crisi letteraria della
Francia dell’epoca. A meno che non sia stato uno di quegli immigrati letterari
che, sulla scia di san Colombano (la cui arma, non dimentichiamolo, erano la
parola e i libri “più dolci del miele”), erano venuti dall’Irlanda a far
rivivere, almeno in ambito colto, il latino proprio perché per loro era una
lingua ex novo e quindi immune da quelle contaminazioni, che oggi ci piacciono
molto, dal parlato (tipo la “c” e la “g” gutturali, come in origine, e non le
nostre dolci “ci” e “gi”). Quelli che insomma avrebbero portato, come ha ben
sottolineato il grande Peter Brown nel suo splendido La formazione dell’Europa cristiana, “una lingua misteriosa, del
tutto aliena” a un “nuovo latino stabile, puro e prevedibile, perché era un
latino morto” dove “a ogni simbolo grafico corrispondeva una unità fonetica”,
per cui “in un mondo in cui ‘directum’ era pronunciato come ‘dreit’ e
‘monasterium’ come ‘moustier’, una regola di pronuncia di questo tipo rendeva
praticamente incomprensibile il latino pronunciato in maniera corretta”.

Ancora qualcosa di difficile comprensione: ma cosa
non lo era in un periodo così poco conosciuto e in tumultuoso cambiamento?
L’imperatore era ancora quello dell’impero bizantino, con cui il sud della
Francia manteneva rapporti commerciali e culturali (Virgilio afferma di saper
leggere il greco e il celare la propria identità dietro il nome di un autore
antico era una moda che veniva dall’oriente). La Chiesa di Roma, mentre
Colombano scendeva sul continente, spediva in Inghilterra nuovi emissari come
Agostino e Lorenzo. Il cristianesimo irlandese privilegiava una data per la
Pasqua non in sintonia con quella sostenuta dal papa e il regno longobardo,
ancora in maggioranza ariano e rivale per eccellenza di quello franco,
accoglieva Colombano e gli concedeva di costruire il monastero di Bobbio. Tutta
una sere di problemi geopolitici e religiosi da cui Virgilio Marone Grammatico
sembra volersi parare nella prefazione alle sue Epistole, indirizzate a un ecclesiastico, Giulio. Nelle Epitomi non aveva mai esplicitato
riferimenti alla religione cristiana e anche se qui non manca di farlo è sempre
a modo suo, tirando fuori da chissà quale sacco un profeta persiano di nome
Tarquinio(!), che avrebbe visto scendere dal cielo un fiume di vino che si
sarebbe mescolato a un ruscello d’acqua sorto dalla terra. Risultato: un unico
torrente di-vino che avrebbe unito cielo e terra: “E tu, fratello diacono
Giulio, ubriaco del bellissimo vino della divina scrittura e della dottrina
celeste, bevi anche da questo piccolo ruscello del sapere filosofico… Condivido
la tua stessa fede”.

Le apparenze – e la sostanza – sono salve e questa
sorta di George Perec del VII secolo può tornare anche nelle Epistole a veicolare una nostalgia di
fondo verso l’antichità pagana esibendo i suoi “auctores” mai esistiti ma fondamentali.
O forse questa apparente divulgazione in una società tornata a un livello quasi
tribale è opera di uno dei tanti esponenti di quelle tribù irlandesi - perché
tale rimase in fondo la struttura politica dell’Irlanda fino ai massacri di Cromwell, ma nel XVII secolo – che avrebbero dato vita a una vera e propria
rinascita culturale e cristiana dell’Europa prima di Carlo Magno e del suo
“ministro della cultura” Alcuino (non a caso di York), che tirò le fila di
tutta questa trama complessa inaugurando una nuova era.

La fortuna dell’opera del Grammatico, infatti, è
quasi tutta di stampo irlandese o inglese. A partire dalle citazioni dai suoi
scritti. Il primo è sant’Aldelmo di Malmesbury (639-709), ex alunno della
scuola irlandese dell’abazia di Iona (isola delle Ebridi), un altro che amava
il latino difficile e conosceva bene anche gli Hisperica Famina (molto probabilmente composti proprio a Iona dopo
la metà del VII secolo). E poi, cosa che mi ha stupito sempre, anche il più
sobrio e misurato Beda il Venerabile (santo e dottore della Chiesa cattolica). Fino
ad arrivare ad Attone vescovo di Vercelli (X sec.). E mai nessuno che alzi la
benché minima condanna! Segno che era preso sul serio. Un maestro, un
caposcuola vero anche se parlava di maestri immaginari. Certamente per questo è
piaciuto a Umberto Eco e sarebbe stato un ottimo soggetto per Borges.
Virgilio aveva dunque fatto bene il suo – surreale
– lavoro. E i codici, specie delle Epitomi,
vennero copiati con un certo successo soprattutto nel IX secolo: bel contrasto
anche questo con la ricerca di chiarezza della scuola carolina! Ma, come ha ben
sottolineato Mirella Ferrari nella sua Nota
sui codici di Virgilio Marone Grammatico, i quattro manoscritti
fondamentali dei suoi testi “hanno origine tutti nell’arco cronologico di soli
cinquant’anni circa (prima metà del sec. IX) in regioni invece piuttosto
disparate: Luxeuil, Ile de France, Corbie, Salisburgo. Il comune denominatore
che li lega è la provenienza da scuole dell’impero carolingio nelle quali la
componente culturale irlandese era attiva o addirittura prevalente”.
Eccola qui che torna l’ipotesi irlandese. Piace
anche a me: un san Brandano della grammatica, con la sua navigazione a vista
attraverso le secche dell’ortodossia religiosa. E se le secche fossero state
anche quelle della nuova ortodossia grammaticale carolingia? È quanto sostiene
Roberto Gamberini nell’articolo Divertirsi
con la grammatica pubblicato su Filologia
mediolatina nel 2014. Un altro
raffinatissimo colpo di scena: sarebbero stati proprio i dotti successori di
Alcuino a intervenire, a infierire con mano pesante e volontà diffamatoria su Epitomi ed Epistole trasformando letteralmente l’insieme in una parodia
satura di aggiunte comiche. La prova? I manoscritti che riportano per intero le
opere del Grammatico sono tutti del IX secolo, mentre le citazioni sparse in
testi di epoca precedente – quelle per
intenderci a cui si sarebbero ispirati Beda o Aldelmo – non sembrano recare
traccia di quella specie di commedia dell’assurdo che tanto ci piace oggi
quanto sarebbe dovuta risultare inconcepibile, irricevibile anche nella fucina
ancora ardente del primo Alto Medioevo. In questo caso ci troveremmo però di
fronte a una specie di cospirazione purista o al pesante intervento strutturale
di uno o più dotti non solo non sanzionato ma addirittura – tacitamente o meno
– pienamente avallato… Ma non sarebbe stata più semplice una congiura del
silenzio invece di questa laboriosa riedizione? Una censura implicita invece di
quattro feroci risate? Occorreva davvero spendere così tanta fatica, per quanto
sinistramente geniale, per infangare la memoria di un grammatico disperso in
un’epoca già ai tempi considerata remota, quando ormai l’onda lunga della
scuola irlandese aveva perso la sua spinta propulsiva? Facevano ancora così
paura gli scritti del misterioso insegnante che si celava dietro il nome del
poeta latino per eccellenza, Virgilio Marone?

Rabano Mauro portato sottobraccio dal maestro Alcuino: due possibili colpevoli...
E se, unendo le tesi di Gamberino
e della Babino, finissimo per conseguire la somma di due persecuzioni, religiosa
e sintattica, da parte dei filologi carolingi, tutti ecclesiastici, tutti custodi
sia del Verbo che dei “verba”, della parola di Dio e delle parole degli uomini?
Una censura doppia, sinistra e laboriosa, di cui non ho trovato altri esempi.
Di certo c’è che dopo l’età
carolingia la navigazione di questa specie di Enea del mare magnum della parola
sembra arenarsi. Ancora un secolo e poco più, alle soglie dell’Anno Mille è il solo Abbone
di Fleury l’ultimo a citarlo (forse). Poi, dopo lo Scisma con Costantinopoli e
la Riforma Gregoriana, la selezione degli scritti da parte della Chiesa di Roma
si fa più oculata: Epitomi ed Epistole non vengono più copiate. Cala il
sipario, oltre il quale si tornerà a sbirciare solo nell’Ottocento.

La grammatica nasce per disinfettare le parole
vive, quasi sempre sanguinanti. Il filologo e il filosofo se le scambiano e
cercano di guardarle come lastre ai raggi X. In caso di malattia, l’analizzano
pensando, sperando di esserne immuni. Mi piace pensare che Virgilio Marone Grammatico o chi per lui
avesse intravisto questa emorragia interna del corpo intellettuale, questa
ferita aperta fra pensiero laico e religioso e avesse cercato di cicatrizzarla usando
parole e regole come esorcismi raziocinanti. Ne sortirono zombie dell’antichità
e Frankenstein per la didattica. Contraddittoria volontà di potenza della
parola.
Anche sul suo nome oggi eravamo solo in 5. Nella
pagina, ottima, virtuale di Wikipedia.
Però ben oltre la media giornaliera di 2.
L’ultima stranezza.
MISTERI LAICI DELLA PAROLA
Frammento teatrale
(senza data)
Virgilio Marone Grammatico
(Rivolto
a quello che resta dei suoi discepoli in mezzo alle rovine dell’anfiteatro di
Purpan-Ancely a Tolosa)
Il
nostro latino è come un esercito invincibile velato di mistero. Siamo rimasti
in pochi, pochissimi, ma la lingua dei romani è ancora quella del potere. Ecco
allora che le nostre labbra non ripetono solo regole: intonano canti di guerra.
Le nostre mani forgiano, impugnano armi degne di un eroe sempre invincibile,
antico. Loro, i barbari, temono solo la scrittura: non dire quella parola e non
sarai salvato. Vedete quindi che i nostri libri sono scudi. Lo stilo che
incide, che scrive è spada, lancia, freccia. L’inchiostro, l’inchiostro è il
vino che ci inebria. Perché ha la stessa natura liquida, inafferrabile del
sangue. È il nostro e dovrà essere quello dei nemici, che in questo inchiostro
si legheranno al nostro sangue col legame inscindibile che ne consegue. Parliamo
e ci armiamo. Ci confronteremo ebbri di queste parole, certi che la vittoria
non si ottiene sul campo ma in quelle clausole dei trattati che sono figlie
nelle nostre regole grammaticali, perché la sintassi è l’ordine che regna sui
fogli bianchi o ripuliti dove le loro schiere disordinate devono restare ai
margini. Le nostra città ha mura di diaspro cristallino e vie intricate come le
nostre riflessioni: righe ben scritte e contenuti celati, dove chi non sa può,
anzi, deve perdersi.














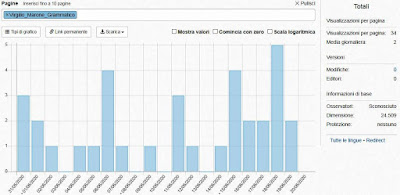

Nessun commento:
Posta un commento